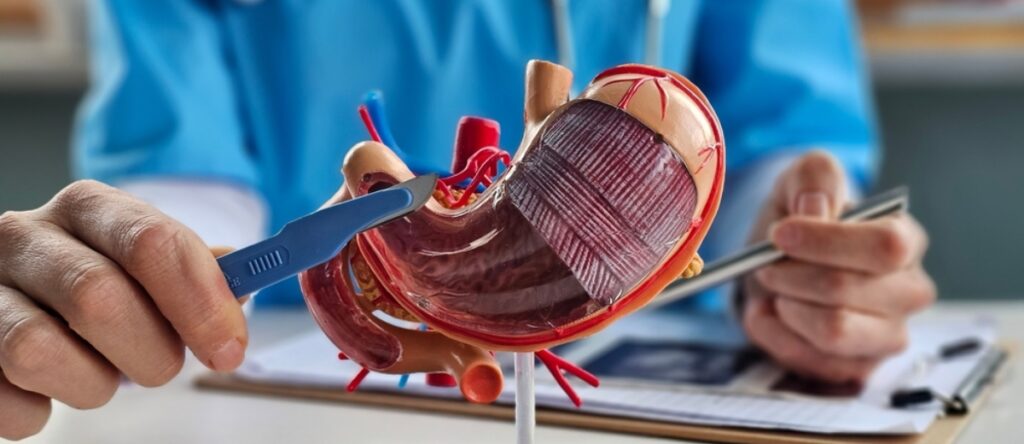
L’ulcera, cos’è e come prevenirla
L’ulcera rappresenta una delle patologie digestive più comuni e può interessare diverse parti del corpo. Quando si parla di ulcera, ci si riferisce generalmente alle ulcere peptiche che colpiscono lo stomaco e il duodeno, ma esistono anche ulcere cutanee che richiedono attenzione medica. Comprendere cosa sono le ulcere, riconoscerne i sintomi e conoscere le strategie di prevenzione è fondamentale per evitare complicazioni potenzialmente gravi.
Cos’è un’ulcera
Un’ulcera è una lesione della mucosa che riveste alcuni organi, caratterizzata dalla perdita di sostanza con formazione di una cavità più o meno profonda. A differenza di una semplice erosione superficiale, l’ulcera penetra oltre lo strato mucoso raggiungendo gli strati sottostanti dei tessuti.
Le ulcere possono svilupparsi in diverse sedi dell’organismo, ma quelle più comuni e clinicamente rilevanti sono le ulcere peptiche del tratto gastrointestinale superiore e le ulcere cutanee degli arti inferiori. Ogni tipo di ulcera ha caratteristiche, cause e trattamenti specifici che richiedono un approccio diagnostico e terapeutico mirato.
Ulcera gastrica e duodenale
Le ulcere peptiche sono lesioni della mucosa dello stomaco (ulcera gastrica) o della prima porzione dell’intestino tenue (ulcera duodenale).
Ulcera gastrica
Caratteristiche specifiche:
- localizzazione prevalente nella piccola curvatura dello stomaco
- più frequente negli adulti oltre i 50 anni
- dolore che tipicamente si manifesta o peggiora durante i pasti
- rischio più elevato di degenerazione maligna rispetto all’ulcera duodenale.
Meccanismo di formazione:
- squilibrio tra fattori aggressivi (acido cloridrico, pepsina) e difensivi (muco, bicarbonato)
- indebolimento della barriera mucosa gastrica
- ridotta capacità di riparazione tissutale
- ischemia locale che compromette la guarigione.
Ulcera duodenale
Caratteristiche distintive:
- più comune dell’ulcera gastrica (rapporto 3:1)
- localizzazione tipica nel bulbo duodenale
- dolore che migliora con l’assunzione di cibo
- picco di incidenza tra 30 e 60 anni
- raramente associata a malignità.
Fattori predisponenti:
- ipersecrezione acida gastrica
- svuotamento gastrico accelerato
- infezione da Helicobacter pylori
- fattori genetici e familiarità.
Ulcere cutanee
Le ulcere cutanee rappresentano un problema significativo, specialmente negli anziani e nei pazienti con patologie vascolari.
Classificazione per eziologia
Ulcere vascolari:
- ulcere venose da insufficienza venosa cronica
- ulcere arteriose da ischemia periferica
- ulcere miste con componente venosa e arteriosa
- localizzazione prevalente agli arti inferiori.
Ulcere da pressione (piaghe da decubito):
- causate da pressione prolungata su prominenze ossee
- comuni in pazienti allettati o con mobilità ridotta
- stadi di gravità crescente da eritema a necrosi profonda
- prevenzione fondamentale con mobilizzazione e cura della cute.
Ulcere diabetiche:
- piede diabetico con perdita di sensibilità
- guarigione rallentata per alterazioni vascolari e neurologiche
- alto rischio di infezione e complicazioni
- necessità di controllo glicemico ottimale.
Ulcere da altre cause:
- lesioni traumatiche che non guariscono
- ulcere neoplastiche
- ulcere da vasculiti o malattie autoimmuni
- ulcere iatrogene da farmaci o radiazioni.
Cause comuni delle ulcere
Le cause delle ulcere peptiche sono ben definite e spesso interconnesse.
Infezione da Helicobacter pylori
Ruolo patogenetico:
- batterio che colonizza la mucosa gastrica
- responsabile del 70-90% delle ulcere duodenali
- causa del 60-70% delle ulcere gastriche
- induce infiammazione cronica della mucosa (gastrite).
Meccanismi di danno:
- produzione di ureasi che neutralizza l’acidità gastrica
- danneggiamento diretto della barriera mucosa
- stimolazione della risposta infiammatoria
- alterazione della secrezione acida e della motilità gastrica.
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
Effetto lesivo sulla mucosa:
- inibizione della sintesi di prostaglandine protettive
- riduzione della produzione di muco e bicarbonato
- diminuzione del flusso sanguigno mucosale
- effetto tossico diretto sulle cellule epiteliali.
Fattori di rischio per ulcera da FANS:
- età superiore a 65 anni
- storia di ulcera o sanguinamento gastrico pregresso
- uso concomitante di anticoagulanti o corticosteroidi
- dosaggi elevati o uso prolungato
- uso combinato di più FANS.
Stress e fattori psicologici
Influenza sul sistema digestivo:
- aumento della secrezione acida da stress cronico
- alterazione della motilità gastrointestinale
- riduzione delle difese mucosali
- modifiche comportamentali (fumo, alcol, alimentazione irregolare).
Altri fattori contributivi
- consumo eccessivo di alcol con effetto erosivo diretto
- fumo di sigaretta che riduce la guarigione e aumenta il rischio
- dieta ricca di cibi piccanti o irritanti
- predisposizione genetica e familiarità
- sindrome di Zollinger-Ellison con ipersecrezione acida.

Come si riconosce un’ulcera
I sintomi delle ulcere peptiche possono variare in intensità e caratteristiche.
Sintomi tipici dell’ulcera gastrica
Dolore epigastrico:
- localizzato nella parte alta e centrale dell’addome (mal di stomaco)
- descritto come bruciore, morso o crampo
- insorgenza o peggioramento durante i pasti
- possibile irradiazione al dorso.
Altri sintomi:
- nausea e vomito, talvolta con tracce di sangue
- perdita di appetito e calo ponderale
- sensazione di pienezza precoce
- gonfiore addominale dopo i pasti.
Sintomi dell’ulcera duodenale
Dolore caratteristico:
- dolore che compare 2-5 ore dopo i pasti
- miglioramento con l’assunzione di cibo o antiacidi
- dolore notturno che risveglia il paziente
- andamento ciclico con periodi di remissione e riacutizzazione.
Sintomi di allarme
Segni di complicazioni:
- vomito con sangue rosso vivo o color caffè
- feci nere e picee (melena) per sanguinamento digestivo
- dolore petto o addominale improvviso e severo (possibile perforazione)
- debolezza, pallore e tachicardia (anemia da sanguinamento cronico)
- perdita di peso significativa e inspiegabile.
Complicazioni delle ulcere
Le ulcere non trattate possono evolvere in complicazioni gravi.
Sanguinamento
- erosione di vasi sanguigni nella base dell’ulcera
- sanguinamento occulto cronico con anemia
- emorragia massiva acuta con instabilità emodinamica
- necessità di intervento endoscopico o chirurgico d’urgenza.
Perforazione
- rottura della parete gastrica o duodenale
- peritonite acuta con addome acuto chirurgico
- mortalità elevata se non trattata tempestivamente
- necessità di intervento chirurgico d’urgenza.
Penetrazione
- estensione dell’ulcera a organi adiacenti
- più frequente nel pancreas per ulcere duodenali posteriori
- dolore persistente che non risponde ai farmaci
- possibili complicazioni negli organi coinvolti.
Stenosi
- restringimento del lume gastrico o duodenale
- conseguenza di ripetute ulcerazioni e cicatrizzazioni
- vomito per ostruzione al passaggio del cibo
- necessità di dilatazione endoscopica o chirurgia.
Trattamento delle ulcere peptiche
Il trattamento moderno delle ulcere è molto efficace e raramente richiede chirurgia.
Terapia farmacologica
Inibitori della pompa protonica (IPP):
- omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo
- riduzione drastica della secrezione acida gastrica
- durata del trattamento 4-8 settimane per guarigione
- mantenimento a lungo termine in casi selezionati.
Antagonisti dei recettori H2:
- ranitidina, famotidina
- alternativa agli IPP nelle forme lievi
- efficacia inferiore rispetto agli inibitori di pompa
- utilizzo meno frequente nella pratica clinica attuale.
Antiacidi e protettori della mucosa:
- neutralizzazione temporanea dell’acidità gastrica
- sucralfato che forma una barriera protettiva
- utilizzo come terapia aggiuntiva sintomatica
- beneficio limitato come monoterapia.
Eradicazione dell’Helicobacter pylori
Terapia tripla standard:
- inibitore di pompa protonica a dose doppia
- claritromicina e amoxicillina (o metronidazolo)
- durata del trattamento 10-14 giorni
- efficacia di eradicazione 70-85%.
Terapie alternative:
- terapia quadrupla con bismuto per resistenze
- terapia sequenziale o concomitante
- terapia di seconda linea dopo fallimento
- test di controllo dell’eradicazione dopo 4-6 settimane.
Gestione dei FANS
- sospensione o riduzione del dosaggio quando possibile
- sostituzione con paracetamolo per il dolore
- gastroprotettori (IPP) in associazione se necessario continuare
- utilizzo di FANS selettivi (COX-2) a minor rischio.
Trattamento chirurgico
Indicazioni attuali limitate:
- complicazioni acute (perforazione, sanguinamento massivo)
- stenosi severa non trattabile endoscopicamente
- fallimento della terapia medica in casi selezionati
- sospetto di malignità nell’ulcera gastrica.
Prevenzione delle ulcere
La prevenzione è possibile agendo sui fattori di rischio modificabili:
Prevenzione primaria
Stile di vita salutare:
- dieta equilibrata con pasti regolari
- riduzione o eliminazione dell’alcol
- cessazione del fumo
- gestione dello stress con tecniche di rilassamento
- attività fisica regolare.
Uso razionale dei farmaci:
- limitare l’uso di FANS allo stretto necessario
- preferire paracetamolo quando possibile
- associare gastroprotettori nei soggetti a rischio
- evitare automedicazione prolungata.
Prevenzione secondaria
Screening e trattamento dell’Helicobacter pylori:
- test in soggetti con sintomi suggestivi
- eradicazione quando positivo
- controllo dell’efficacia del trattamento
- screening in familiari di pazienti con tumore gastrico.
Gastroprotezione nei soggetti a rischio:
- IPP profilattici in pazienti in terapia cronica con FANS
- protezione in politerapia con anticoagulanti
- monitoraggio in pazienti con storia di ulcera
- dosaggi e durata personalizzati.
Controlli periodici
- gastroscopia di follow-up per ulcere gastriche
- verifica della guarigione completa
- sorveglianza in pazienti con fattori di rischio persistenti
- educazione del paziente sui segnali di allarme.
Le ulcere peptiche, pur essendo condizioni potenzialmente gravi, possono essere efficacemente prevenute e trattate con l’approccio terapeutico moderno. La comprensione dei fattori di rischio, il riconoscimento tempestivo dei sintomi e l’aderenza alla terapia prescritta rappresentano gli elementi chiave per una gestione ottimale e la prevenzione delle complicazioni.





